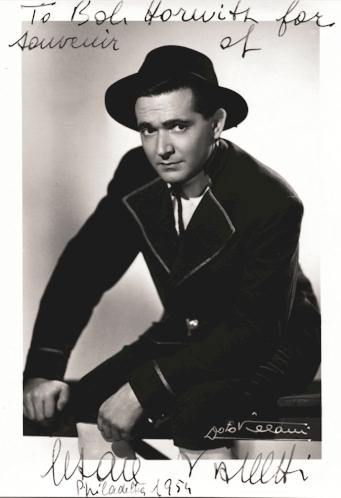Le celebrazioni del centenario della prima assoluta della Fanciulla del West, ricorrenza accompagnata da peana della carta stampata in cui fiorivano i paralleli fra il primo interprete e l’attuale del bandito Ramerrez, quasi che i due cantanti fossero non dico simili, ma comparabili, al di là delle origini geografiche, hanno indotto e spronato i compilatori del Corriere della Grisi a consultare le cronologie del teatro americano relative al periodo della première. Diciamo quelli del Corriere sono stati provocati a guardare attorno non già a questa celebrazione, ma alla prima esecuzione del titolo pucciniano.
Le celebrazioni del centenario della prima assoluta della Fanciulla del West, ricorrenza accompagnata da peana della carta stampata in cui fiorivano i paralleli fra il primo interprete e l’attuale del bandito Ramerrez, quasi che i due cantanti fossero non dico simili, ma comparabili, al di là delle origini geografiche, hanno indotto e spronato i compilatori del Corriere della Grisi a consultare le cronologie del teatro americano relative al periodo della première. Diciamo quelli del Corriere sono stati provocati a guardare attorno non già a questa celebrazione, ma alla prima esecuzione del titolo pucciniano.Non si tratta, checché ne possano pensare i detrattori per partito preso, di cattiveria e animosità nei confronti dei protagonisti dell’attualità operistica, semmai del desiderio di comprendere o sforzarsi di comprendere al meglio la fondatezza delle pretese di eccellenza e innovazione che i suddetti protagonisti accampano, anche e soprattutto per il tramite della stampa cosidetta specializzata. Eccellenza e innovazione rispetto a un passato in cui il repertorio era ridotto a pochi titoli (voce assolutamente indimostrata), sempre gli stessi, e gli esecutori non potevano vantare che una conoscenza molto approssimativa non solo dei meccanismi del teatro di regia, gli unici in grado di garantire, a detta di alcuni, la perfetta riuscita di uno spettacolo lirico, ma anche della musica, che esulasse da quel limitatissimo repertorio.
È sufficiente scorrere gli archivi del Met relativi a un paio di mesi scarsi, dalla metà di novembre alla fine di dicembre del 1910, per rendersi conto che gli spettatori newyorkesi ebbero modo di assistere, in quel breve lasso di tempo, a due prime assolute (oltre alla Fanciulla, Koenigskinder di Humperdinck) e alla prima statunitense dell’Armide gluckiana. Quanto, poi, a un titolo in teoria di grande repertorio, nei fatti oggi scomparso o quasi dai cartelloni, la Gioconda venne proposta con un cast di lusso a dir poco sfrenato (fra l’altro coincidente, in buona misura, con quello della Fanciulla e affidato alla stessa illustre bacchetta, che non disprezzava certo il buon Ponchielli). Wagner, del quale è imminente il secondo centenario dalla nascita, venne affrontato, sempre in quei due "mesetti", da tutti o quasi i maggiori interpreti del tempo, segnatamente in corda di tenore.
Scusate ma non è da tutti proporre nel medesimo titolo Leo Slezak e Carl Burrian, o ancora Karl Jorn e Hermann Jadlowker. Peraltro gli stessi interpreti affrontavano con la medesima disinvoltura e appropriatezza stilistica (documentata dai reperti fonografici) anche i titoli del repertorio italiano coevo o passato.
Accertata e documentata anche la predilezione del teatro newyorkese per le cantanti di giovane e gentile aspetto, quali Geraldine Farrar, peraltro costrette a ritmi lavorativi inaffrontabili in difetto di una preparazione tecnica, degna di questo nome, e per le dive sul viale del tramonto, come Nellie Melba, alla sua ultima apparizione metropolitana quale Violetta. La scelta dei colleghi con cui queste fascinose signore si esibivano era, a ogni modo, sempre e comunque sotto il segno del lusso e dello sfarzo, tanto che la cornice finisce per impressionare, oggi, assai più del quadro che avrebbe dovuto porre in risalto. E in ogni caso le dive o divastre non toglievano spazio, o almeno, non completamente, a solide cantanti di attuale poca o nulla fama, quale Lydia Lipkowska, che nell’estratto del Rigoletto che proponiamo in appendice dimostra doti timbriche e sapienza tecnica, che la signora avrebbe in buona misura trasfusa nella sua più celebre e celebrata allieva: Virginia Zeani.
E con questo ci fermiamo, anche per consentire ai lettori di esplorare a proprio talento, ponderare, considerare.
Davanti a tanto lusso ciascuno di noi ha due scelte. Entrambe di fatto impossibili. Augurarsi di possedere la macchina del tempo e scegliere uno di questi spettacoli, con scene di cartapesta, fondali dipinti, soprani di forte complessione e calzanti cornuti elmi e addobbi da processione, e questa è la scelta dei passatisti, grisini, grisalidi. Oppure provare a pensare di allestire una identica programmazione, scritturando i divi di oggi ossia quei soprani, che surclassano una Morena, piuttosto che una Farrar o i tenori, che belli e bravi ridicolizzano il cimelio di Hermann Jadlowker. E sono gli accoliti del teatro di regia, del passato rinnegato, delle auspicate disintossicazioni da 78 giri e affini.
Sono certo che il risultato sarà per entrambe le categorie quello della sezione conclusiva del sogno di Tosti.
Metropolitan Opera House
November 14, 1910
Opening Night {26}
Giulio Gatti-Casazza, General Manager
United States Premiere
ARMIDE {1}
C. W. Gluck-Quinault
Armide..................Olive Fremstad
Renaud..................Enrico Caruso
Hate....................Louise Homer
Hidraot.................Pasquale Amato
Phénice.................Jeanne Maubourg
Sidonie.................Lenora Sparkes
Ubalde..................Dinh Gilly
Danish Knight...........Angelo Badà
Lucinde.................Alma Gluck
Artémidore..............Albert Reiss
Aronte..................Andrés De Segurola
Naiad...................Marie Rappold
Love....................Alma Gluck
Act I Incidental dance: Corps de ballet
Act II Dance of the Shepherds: Lucia Fornaroli [Debut], Anna Mariani [Debut], and corps de ballet
Act III Dance Inferanale: Gina Torriani, Lucia Fornaroli, Marcelle Myrtille, and corps de ballet
Act IV Dance of the Shepherds: Lucia Fornaroli, Anna Mariani, and corps de ballet
Act V Divertissement: Gina Torriani, Lucia Fornaroli, and corps de ballet
Conductor...............Arturo Toscanini
Albany, New York
Harmanus Bleecker Hall
November 15, 1910
MADAMA BUTTERFLY {54}
Puccini-Illica/Giacosa
Cio-Cio-San.............Geraldine Farrar
Pinkerton...............Riccardo Martin
Suzuki..................Marie Mattfeld
Sharpless...............Antonio Scotti
Goro....................Angelo Badà
Bonze...................Bernard Bégué
Yamadori................Georges Bourgeois
Kate Pinkerton..........Helen Mapleson
Commissioner............Vincenzo Reschiglian
Yakuside................Francesco Cerri
Conductor...............Arturo Toscanini
Metropolitan Opera House
November 16, 1910
Revised production
TANNHÄUSER {178}
Wagner-Wagner
Tannhäuser..............Leo Slezak
Elisabeth...............Berta Morena
Wolfram.................Walter Soomer
Venus...................Olive Fremstad
Hermann.................Allen Hinckley
Walther.................Albert Reiss
Heinrich................Julius Bayer
Biterolf................William Hinshaw [Debut]
Reinmar.................Frederick Gunther
Shepherd................Lenora Sparkes
Page....................Lenora Sparkes
Page....................Anna Case
Page....................Lillia Snelling
Page....................Henriette Wakefield
Dance...................Lucia Fornaroli
Dance...................Marcelle Myrtille
Dance...................Gina Torriani
Conductor...............Alfred Hertz
Metropolitan Opera House
November 17, 1910
AIDA {159}
Giuseppe Verdi--Antonio Ghislanzoni
Aida....................Emmy Destinn
Radamès.................Enrico Caruso
Amneris.................Louise Homer
Amonasro................Pasquale Amato
Ramfis..................Adamo Didur
King....................Giulio Rossi
Messenger...............Pietro Audisio
Priestess...............Rita Fornia
Dance...................Gina Torriani
Conductor...............Arturo Toscanini
Metropolitan Opera House
November 18, 1910
DIE WALKÜRE {140}
Wagner-Wagner
Brünnhilde..............Lucie Weidt [Debut]
Siegmund................Carl Burrian
Sieglinde...............Berta Morena
Wotan...................Walter Soomer
Fricka..................Florence Wickham
Hunding.................Basil Ruysdael [Debut]
Gerhilde................Lenora Sparkes
Grimgerde...............Henriette Wakefield
Helmwige................Rita Fornia
Ortlinde................Rosina Van Dyck
Rossweisse..............Inga Örner
Schwertleite............Paula Wöhning [Last performance]
Siegrune................Marie Mattfeld
Waltraute...............Florence Wickham
Conductor...............Alfred Hertz
New York, Brooklyn
November 19, 1910
IL TROVATORE {84}
Giuseppe Verdi--Salvatore Cammarano
Manrico.................Leo Slezak
Leonora.................Marie Rappold
Count Di Luna...........Pasquale Amato
Azucena.................Louise Homer
Ferrando................Herbert Witherspoon
Ines....................Emma Borniggia
Ruiz....................Pietro Audisio
Gypsy...................Edoardo Missiano
Conductor...............Vittorio Podesti
Metropolitan Opera House
November 21, 1910
LA BOHÈME {92}
Puccini-Illica/Giacosa
Mimì....................Geraldine Farrar
Rodolfo.................Hermann Jadlowker
Musetta.................Bella Alten
Marcello................Antonio Scotti
Schaunard...............Adamo Didur
Colline.................Andrés De Segurola
Benoit..................Antonio Pini-Corsi
Alcindoro...............Antonio Pini-Corsi
Parpignol...............Pietro Audisio
Sergeant................Edoardo Missiano
Officer.................Pietro Audisio
Conductor...............Arturo Toscanini
Metropolitan Opera House
November 23, 1910
LA GIOCONDA {39}
Ponchielli-Boito
La Gioconda.............Emmy Destinn
Enzo....................Enrico Caruso
Laura...................Louise Homer
Barnaba.................Pasquale Amato
Alvise..................Andrés De Segurola
La Cieca................Maria Claessens [Debut]
Zuàne...................Bernard Bégué
Isèpo...................Pietro Audisio
Singer..................Edoardo Missiano
Conductor...............Arturo Toscanini
Metropolitan Opera House
November 24, 1910 Matinee
PARSIFAL {59}
Wagner-Wagner
Parsifal................Carl Burrian
Kundry..................Olive Fremstad
Amfortas................Pasquale Amato
Gurnemanz...............Herbert Witherspoon
Klingsor................Otto Goritz
Titurel.................William Hinshaw
Voice...................Henriette Wakefield
First Esquire...........Lenora Sparkes
Second Esquire..........Henriette Wakefield
Third Esquire...........Albert Reiss
Fourth Esquire..........Glenn Hall
First Knight............Julius Bayer
Second Knight...........William Hinshaw
Flower Maidens: Lenora Sparkes, Rita Fornia, Rosina Van Dyck,
Bella Alten, Marie Mattfeld, Henriette Wakefield
Conductor...............Alfred Hertz
Metropolitan Opera House
November 24, 1910
RIGOLETTO {69}
Giuseppe Verdi--Francesco Maria Piave
Rigoletto...............Maurice Renaud [Debut]
Gilda...................Nellie Melba
Duke of Mantua..........Florencio Constantino [Debut]
Maddalena...............Marianne Flahaut
Sparafucile.............Adamo Didur
Monterone...............Giulio Rossi
Borsa...................Angelo Badà
Marullo.................Bernard Bégué
Count Ceprano...........Vincenzo Reschiglian
Countess Ceprano........Helen Mapleson
Giovanna................Marie Mattfeld
Page....................Emma Borniggia
Conductor...............Vittorio Podesti
Metropolitan Opera House
November 25, 1910
CAVALLERIA RUSTICANA {131}
Mascagni-Targioni-Tozzetti/Menasci
Santuzza................Emmy Destinn
Turiddu.................Riccardo Martin
Lola....................Jeanne Maubourg
Alfio...................Dinh Gilly
Mamma Lucia.............Marie Mattfeld
Conductor...............Vittorio Podesti
Director................Jules Speck
Set Designer............Mario Sala
Set Designer............Angelo Parravicini
Costume Designer........Maison Chiappa
Cavalleria Rusticana received eight performances this season.
PAGLIACCI {112}
Leoncavallo-Leoncavallo
Nedda...................Bella Alten
Canio...................Enrico Caruso
Tonio...................Pasquale Amato
Silvio..................Dinh Gilly
Beppe...................Angelo Badà
Conductor...............Vittorio Podesti
New York, Brooklyn
November 26, 1910
ORFEO ED EURIDICE {18}
C. W. Gluck-Calzabigi
Orfeo...................Louise Homer
Euridice................Marie Rappold
Amore...................Lenora Sparkes
Happy Shade.............Alma Gluck
Dance...................Marcelle Myrtille
Conductor...............Arturo Toscanini
Metropolitan Opera House
November 28, 1910
LOHENGRIN {258}
Wagner-Wagner
Lohengrin...............Hermann Jadlowker
Elsa....................Berta Morena
Ortrud..................Louise Homer
Telramund...............Walter Soomer
King Heinrich...........Allen Hinckley
Herald..................William Hinshaw
Noble...................Julius Bayer
Noble...................Ludwig Burgstaller
Noble...................Adolf Fuhrmann [Debut]
Noble...................Marcel Reiner
Page....................Lenora Sparkes
Page....................Anna Case
Page....................Lillia Snelling
Page....................Henriette Wakefield
Conductor...............Alfred Hertz
Metropolitan Opera House
November 29, 1910
LA TRAVIATA {77}
Giuseppe Verdi--Francesco Maria Piave
Violetta................Nellie Melba [Last performance]
Alfredo.................John McCormack [Debut]
Germont.................Carlo Galeffi [Debut]
Flora...................Jeanne Maubourg
Gastone.................Pietro Audisio
Baron Douphol...........Vincenzo Reschiglian
Marquis D'Obigny........Bernard Bégué
Dr. Grenvil.............Giulio Rossi
Annina..................Marie Mattfeld
Dance...................Gina Torriani
Conductor...............Vittorio Podesti
New York, Brooklyn
December 3, 1910
TANNHÄUSER {179}
Tannhäuser..............Carl Burrian
Elisabeth...............Lucie Weidt
Wolfram.................Otto Goritz
Venus...................Olive Fremstad
Hermann.................Allen Hinckley
Walther.................Glenn Hall
Heinrich................Julius Bayer
Biterolf................William Hinshaw
Reinmar.................Frederick Gunther
Shepherd................Lenora Sparkes
Page....................Inga Örner
Page....................Anna Case
Page....................Lillia Snelling
Page....................Henriette Wakefield
Dance...................Lucia Fornaroli
Dance...................Marcelle Myrtille
Dance...................Gina Torriani
Conductor...............Alfred Hertz
Metropolitan Opera House
December 10, 1910 Matinee
FAUST {278}
Gounod-Barbier/Carré
Faust...................Hermann Jadlowker
Marguerite..............Geraldine Farrar
Méphistophélès..........Léon Rothier [Debut]
Valentin................Dinh Gilly
Siebel..................Rita Fornia
Marthe..................Marie Mattfeld
Wagner..................Bernard Bégué
Conductor...............Vittorio Podesti
Metropolitan Opera House
December 10, 1910
World Premiere
In the presence of the composer
LA FANCIULLA DEL WEST {1}
Puccini-Civinini/Zangarini
Minnie..................Emmy Destinn
Dick Johnson............Enrico Caruso
Jack Rance..............Pasquale Amato
Joe.....................Glenn Hall
Handsome................Vincenzo Reschiglian
Harry...................Pietro Audisio
Happy...................Antonio Pini-Corsi
Sid.....................Giulio Rossi
Sonora..................Dinh Gilly
Trin....................Angelo Badà
Jim Larkens.............Bernard Bégué
Nick....................Albert Reiss
Jake Wallace............Andrés De Segurola
Ashby...................Adamo Didur
Post Rider..............Lamberto Belleri [Debut]
Castro..................Edoardo Missiano
Billy Jackrabbit........Georges Bourgeois
Wowkle..................Marie Mattfeld
Conductor...............Arturo Toscanini
Metropolitan Opera House
December 12, 1910
CAVALLERIA RUSTICANA {133}
Santuzza................Emmy Destinn
Turiddu.................Hermann Jadlowker
Lola....................Florence Wickham
Alfio...................Dinh Gilly
Mamma Lucia.............Marie Mattfeld
Conductor...............Vittorio Podesti
PAGLIACCI {114}
Nedda...................Bella Alten
Canio...................Enrico Caruso
Tonio...................Pasquale Amato
Silvio..................Dinh Gilly
Beppe...................Angelo Badà
Conductor...............Vittorio Podesti
Philadelphia, Pennsylvania
December 13, 1910
TANNHÄUSER {180}
Tannhäuser..............Leo Slezak
Elisabeth...............Berta Morena
Wolfram.................Walter Soomer
Venus...................Olive Fremstad
Hermann.................Allen Hinckley
Walther.................Glenn Hall
Heinrich................Julius Bayer
Biterolf................William Hinshaw
Reinmar.................Frederick Gunther
Shepherd................Lenora Sparkes
Page....................Inga Örner
Page....................Anna Case
Page....................Lillia Snelling
Page....................Henriette Wakefield
Dance...................Lucia Fornaroli
Dance...................Marcelle Myrtille
Dance...................Gina Torriani
Conductor...............Alfred Hertz
Metropolitan Opera House
December 22, 1910
LOHENGRIN {260}
Lohengrin...............Carl Jörn
Elsa....................Berta Morena
Ortrud..................Florence Wickham
Telramund...............Walter Soomer
King Heinrich...........Allen Hinckley
Herald..................William Hinshaw
Noble...................Julius Bayer
Noble...................Ludwig Burgstaller
Noble...................Adolf Fuhrmann
Noble...................Marcel Reiner
Page....................Inga Örner
Page....................Anna Case
Page....................Lillia Snelling
Page....................Henriette Wakefield
Conductor...............Alfred Hertz
Metropolitan Opera House
December 24, 1910
CAVALLERIA RUSTICANA {134}
Santuzza................Berta Morena
Turiddu.................Riccardo Martin
Lola....................Marianne Flahaut
Alfio...................Pasquale Amato
Mamma Lucia.............Marie Mattfeld
Conductor...............Vittorio Podesti
Metropolitan Opera House
December 28, 1910
World Premiere
KÖNIGSKINDER {1}
Humperdinck-Rosmer
Goosegirl...............Geraldine Farrar
King's Son..............Hermann Jadlowker
Witch...................Louise Homer
Fiddler.................Otto Goritz
Woodcutter..............Adamo Didur
Broommaker..............Albert Reiss
Broommaker's Child......Edna Walter [Debut]
Broommaker's Child......Lotte Engel [Debut]
Innkeeper...............Antonio Pini-Corsi
Innkeeper's Daughter....Florence Wickham
Stable Maid.............Marie Mattfeld
Gatekeeper..............Herbert Witherspoon
Gatekeeper..............William Hinshaw
Councillor..............Marcel Reiner
Tailor..................Julius Bayer
Conductor...............Alfred Hertz
Metropolitan Opera House
December 30, 1910
RIGOLETTO {70}
Giuseppe Verdi--Francesco Maria Piave
Rigoletto...............Pasquale Amato
Gilda...................Lydia Lipkowska
Duke of Mantua..........Dmitri Smirnoff [Debut]
Maddalena...............Marianne Flahaut
Sparafucile.............Andrés De Segurola
Monterone...............Giulio Rossi
Borsa...................Angelo Badà
Marullo.................Bernard Bégué
Count Ceprano...........Vincenzo Reschiglian
Countess Ceprano........Helen Mapleson
Giovanna................Marie Mattfeld
Page....................Emma Borniggia
Conductor...............Vittorio Podesti
Gli ascolti
Gluck - Orfeo ed Euridice
Atto I - Addio miei sospiri - Louise Homer (1903)
Verdi - Rigoletto
Atto I - Caro nome - Lydia Lipkowska (1914)
Verdi - Il Trovatore
Atto III - Ah sì, ben mio - Leo Slezak (1906)
Verdi - La Traviata
Atto I - Ah fors'è lui...Sempre libera - Nellie Melba (1904)
Atto II - Lunge da lei...De' miei bollenti spiriti - John McCormack (1910)
Verdi - Aida
Atto I - Celeste Aida - Enrico Caruso (1911)
Atto III - O patria mia - Emmy Destinn (1914)
Ponchielli - La Gioconda
Atto IV - Suicidio - Emmy Destinn (1914)
Gounod - Faust
Atto III - Ah! je ris de me voir si belle - Geraldine Farrar (1908)
Wagner - Tannhäuser
Atto II - Dich, teure Halle - Olive Fremstad (1911)
Wagner - Lohengrin
Atto III - In fernem Land - Karl Jorn (1909)
Wagner - Die Walküre
Atto I - Der Männer Sippe - Berta Morena (1907)
Atto I - Winterstürme - Carl Burrian (1911)
Leoncavallo - Pagliacci
Prologo - Pasquale Amato (1915)
Puccini - La Bohème
Atto I - Che gelida manina - Hermann Jadlowker (1912)
Atto III - Mimì! Speravo di trovarvi qui - Antonio Scotti & Geraldine Farrar (1908)
Puccini - Madama Butterfly
Atto II - Ora a noi - Antonio Scotti & Geraldine Farrar (1908)